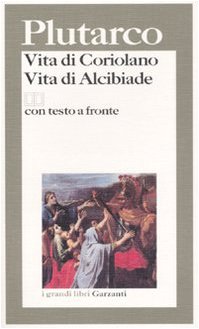Vicende politiche, costituzionali, economiche. Per non parlare delle imprese (e delle rivoluzioni) di Attila, Giustiniano, Carlo Magno, Federico II, Gregorio VIII. Accanto alla tradizione alta da tempo la storiografia specialistica ha riconosciuto l’importanza delle faccende quotidiane di una massa di ignoti.
Poveri, servi, schiavi, contadini, artigiani, commercianti, esuli, mendicanti, apolidi. E non si tratta di atteggiamenti esegetici o di “preferenze”; è fin troppo ovvio ricordare che il problema concerne la documentazione di cui disponiamo. Spesso esigua e poco attendibile o, peggio, inesistente se cerchiamo di ricostruire la storia degli ignoti.
Nonostante queste difficoltà oggettive, il rapporto tra cultura (e storia) alta e cultura (e storia) popolare non è un campo inesplorato. Oggi vorrei spendere qualche parola sul contesto sociale ed economico in cui si sviluppano, in epoca carolingia, l’immagine del contadino e l’immagine dell’intellettuale.
L’argomento che ho scelto è anche un’occasione per segnalarti due libri (molto diversi tra loro) che ho trovato ricchi di spunti per comprendere questa “fase” del Medioevo: Eileen Power, Vita nel Medioevo, Einaudi, e Alcuino di York, Giochi matematici alla corte di Carlo magno, a cura di Raffaella Franci, edito da ETS.
L’immagine del contadino. Come accennavo prima, la cultura orale delle classi subalterne dell’Europa preindustriale tende a non lasciare tracce. O, peggio, a lasciarne di deformate. Ciò posto, è fin troppo evidente che l’immagine del contadino non sia solo quella tramandataci da Andrea Cappellano (nel De amore) o dal Boccaccio. Non credi?
Il libro di Eileen Power, oltre ad essere un piacevole “romanzo”, ha il pregio di dare un nome e un volto ad uno dei tanti stereotipi medievali. Un contadino, un viaggiatore, una badessa, una donna di casa, un mercante ed un fabbricante di panno. La Power ce li presenta immersi nella loro vita quotidiana catapultandoci nelle case e nelle strade dell’Europa medievale. Al di là del discorso che si potrebbe fare sulle figure femminili, sul piano della storia sociale ed economica mi hanno appassionata le giornate di Bodo il contadino e della moglie Ermetrude, sempre di corsa in giro per il manso, tra tributi ed esazioni, fiere e incontri con i Missi Dominici.
Chi è Bodo? E tu, come lo immagini? Posso dirti che, nonostante la durezza dei tempi, è estremamente umano, non certo il contadino meschino e gretto dei racconti cortesi. Ama la sua famiglia, ha un animo vivace e giocoso – balla e canta durante le feste popolari, notoriamente odiate dai monaci – e avvia i figli, soprattutto il più grande Wido, verso la sua futura vita da contadino. Contadino, marito, padre, maestro.
Bodo è un contadino del IX secolo. La fonte principale usata dall’autrice è un libro catastale probabilmente compilato da un abate per sapere con quali terre appartenessero all’abbazia e a chi fossero date in gestione. Ti ricordo che tra il VI e il IX secolo si assiste al fenomeno dell’economia curtense che caratterizza in modo specifico la vita economica dell’Alto Medioevo. La villa o curtis era un vero e proprio centro di residenza e produzione: fattoria, azienda agraria, laboratori. I terreni appartenenti all’abbazia erano divisi in fiscs che erano dei fondi tanto grandi da poter essere amministrati da un fattore.
Ognuno di questi era diviso in terre tributarie e terre signorili: le prime erano divise in quantità più piccole chiamate mansi ed abitate da coloni, mentre le seconde erano amministrate direttamente dai monaci tramite i fattori. L’elemento caratteristico dell’economia curtense è la presenza di una serie di prestazioni d’opera che i tenutari o mansi erano tenuti ad offrire al dominus sotto forma di corvées lavorative. Bodo è inserito in questo contesto sociale ed economico.
L’immagine dell’intellettuale. La vita di questi secoli appare conservativa, popolata da contadini, liberi o servi, che insieme alle loro famiglie coltivavano i campi. Un’economia che mirava all’autosufficienza alimentare, integrata con la caccia e la pesca, in cui lo scambio era minimo in quanto riservato solo alle (spesso misere) eccedenze produttive.
Pur non essendo tecnicamente incompatibile con i commerci, il sistema curtense appare caratterizzato da una vocazione centripeta alla sussistenza, senza alcuna visione d’insieme o di lungo periodo che, forse, avrebbe potuto favorire maggiormente gli scambi.

Questa relativa stagnazione economica sembra essere l’immagine in negativo della rinascita culturale. Tutti gli storici sono concordi nel dire che il regno di Carlo Magno coincise con un generale risveglio della cultura in tutto l’Occidente. Non credere alla storiella della cultura in balìa alle biblioteche monastiche, eh! Certo, una iniziale spinta si ha proprio grazie alla formazione delle prime scuole cristiane (si pensi al caso di Clemente Alessandrino di cui ho parlato in questo video).
Ma non va dimenticato che si stavano organizzando le prime scuole che, pur essendo gestite dal clero, erano aperte ai giovani appartenenti alle famiglie aristocratiche. Carlo Magno pensava che la cultura fosse un elemento essenziale per migliorare lo stato del pubblico servizio; pur essendo quasi analfabeta, non esitava ad intervenire in questioni di scienza, filosofia e teologia (basti ricordare il caso dei Libri Carolini). Attorno al sovrano, proprio ad Acquisgrana si riuniva la Schola Palatina, un circolo di dotti coordinato da un monaco benedettino, Alcuino di York.
Nel 781 Carlo Magno e Alcuino si incontrano a Pavia. Come rifiutare l’offerta di lavorare al suo servizio? Alcuino ha il compito di organizzare le scuole e formulare il programma da seguire, rispettando la divisione canonica tra trivio e quadrivio. Si fa inviare libri dai monasteri inglesi, istituisce scriptoria per copiare i manoscritti, contribuisce alla creazione di veri e propri manuali di insegnamento.
Nel libro Alcuino di York, Giochi matematici alla corte di Carlo magno, a cura di Raffaella Franci, trovate una serie di giochi matematici tratta dalle Propositiones, la più antica collezione di problemi matematici in latino attualmente conosciuta. Il libro è prezioso non solo sul piano della storia della matematica ma anche per rendersi conto delle analogie/differenze tra le soluzioni di Alcuino e quelle moderne. L’immagine dell’intellettuale non è dunque quella del monaco rinchiuso nello scriptorium. Allo stereotipo si sostituisce una figura attiva, dedita alla ricerca e all’insegnamento.
Bibliografia:
Eileen Power, Vita nel Medioevo, Einaudi.
Alcuino di York, Giochi matematici alla corte di Carlo magno, a cura di Raffaella Franci, ETS.